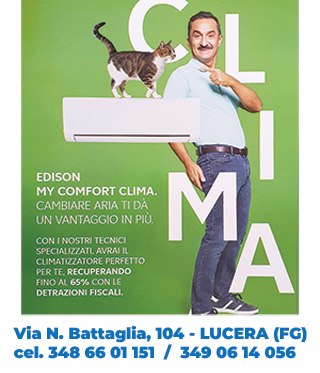Alessandro La Volpe nacque a Lucera il 27 febbraio 1819 da Nicola e da Maria Giuseppa Ra-dicchio, entrambi di Conversano. Il padre era giunto a Lucera come “impiegato”, ovvero maestro di disegno del “Real Collegio”, dove, animato da spirito patriottico, si diede a propagare idee liberali tra i discepoli, per questo fu inserito nella categoria dei presunti rei di “ribellione” – per aver “trascinato nella setta scolari e colleghi del Real Collegio di Lucera” -, e, dopo i fatti del 1820, fu “processato come pervertitore dei suoi discepoli” e “relegato in altra città (Napoli?), lungi dall’abituale sede”,1 ove si stabilì con la famiglia e si affermò “come buon pittore accademico, calcografo e restauratore”.2 A Napoli il figlio Alessandro compì gli studi e, influenzato dall’attività pittorica del padre, prese a frequentare il Real Istituto di Belle Arti, avendo per maestri Gabriele Smargiassi – cui fu molto vicino nell’arte – e Salvatore Fergola (già allievo di Anton Sminck Pitloo); strinse amicizia con gli insigni artisti Filippo Palizzi, Domenico Morelli, Bernardo Celentano, Giacinto Gigante. Attratto in modo particolare dalla espressione pittorica – “maniera rosea” – dello Smargiassi, appunto, e del Palizzi, divenne esponente di rilievo della seconda generazione della Scuola di Posillipo, i cui rappresentanti tra il 1820 e il 1860, studiando e dipingendo all’aperto, e usando ogni espediente pittorico pur di giungere “alla conquista della verità”, si davano ad illustrare i più caratteristici luoghi di quella che era stata la Campania felix: paesaggi, luoghi, costumi, monumenti di Napoli e del Regno. E in questa tendenza Alessandro La Volpe si distinse per il particolarismo dei suoi ampi paesaggi, prediligendo gli affascinanti panorami del golfo di Napoli, visto da Posillipo, le vedute della costa amalfitana, di Pompei, di Paestum, di Salerno e delle isole Ischia, Nisida e Capri, nonché le vi ste collinari, le radure e i piccoli porti con barche e pescatori. Nel 1848 esordì all’esposizione Borbonica con due dipinti: Templi di Paestum e Grotta di Bonea.
Aveva oltre trent’anni quando fu scelto (1851) per accompagnare, nei loro viaggi, l’imperatrice delle Russie in Sicilia e il duca Massimiliano di Leuchtenberg in Egitto, nel corso dei quali, realizzando non poche splendide vedute di luoghi e monumenti, che rivelavano la sua precisa capacità compositiva e la sua eccezionale abilità nella riproduzione degli ambienti e degli oggetti, ebbe modo di “schiarire la propria tavolozza e di studiare con attenzione gli effetti di luce”, varianti “a seconda dell’ora del giorno, premessa per la conquista di quei suoi personalissimi toni rosati e rugginosi tra cielo e terra (natura, edifici e rovine) da cui egli non si allontanerà più, facendone la sua cifra (anche sentimentale), e tali che alla lunga” andarono “di traverso ad alcuni critici del Novecento, come Michele Biancale”.3 Tornò da quei viaggi, dunque, arricchito della nuova esperienza degli studi eseguiti en plein air, in cui dimostrò di saper cogliere in modo straordinario i giochi della luce sugli antichi monumenti, con “quella sua maniera larga e disinvolta” per “un lungo studio fatto dal vero” (B. Magni). E con questa sua particolare capacità si recò a Firenze (1854), ove da Se rafino De Tivoli fu introdotto nel gruppo dei pittori della Scuola Romantica del paesaggio, o Scuola di Staggia, così detta dalla località della campagna senese in cui si incontravano per dipingere dal vivo, all’aperto; tra essi erano Saverio Altamura – patriota in volontario esilio, che fungeva da guida -, Lorenzo Gelati, Carlo Ademollo, i fratelli Carlo e Andrea Markò, tutti anticipatori dei macchiaioli toscani.
Tornato a Napoli tra i paesaggisti della Scuola di Posillipo, divenne l’alter ego di Giacinto Gigante, in quella scuola che, usando una solida tecnica e servendosi della tradizione scientifica nel professare il naturalismo e il genere di pittura dal vero, fece di Napoli il centro di quel nuovo indirizzo pittorico, che si diffuse e fu imitato in Europa e in America. Sempre a Napoli partecipò a varie mostre annuali organizzate dalla Promotrice di Belle Arti di Napoli: nel 1863 espose Bagno, Paesaggio e Castello di Staggia; nel 1864 Il Tempio di Humbos nell’alto Egitto e Marina di Paestum; nel 1866 la splendida veduta Panorama di Pompei, esposta l’anno dopo a Parigi e premiata con medaglia d’oro.
Nel 1870 (10 luglio), in riconoscimento delle sue eccellenti capacità di paesaggista, fu eletto professore onorario dell’Accademia di Belle Arti di Napoli. A Roma, dove intanto si era trasferito, cominciò a esporre con assiduità – fino all’anno della sua morte – alle mostre organizzate dalla Società degli amatori e cultori; alla LI mostra del 1880 partecipò con l’opera Napoli da Frisio. Sempre a Roma aprì un proprio studio in via Margutta, in cui splendeva e si ammirava tutta una serie di dipinti dei più caratteristici siti di Napoli, di Sicilia e di Egitto, nonché riproduzioni di alberi, piante, scogli, rovine e soggetti simili da lui ottimamente ritratti, che l’illustre critico Basilio Magni invitava a visitare: “Vadano gli amatori delle cose belle a rimirare i dipinti di così ingegnoso artefice”. L’11 ottobre 1882 sposò Angela (o Angiola) Molaioli.
Instancabile artista, “fuori della pittura e della famiglia non ebbe altre passioni o distrazioni”. Lavorava tutto il giorno senza sosta, dal mattino alla sera, e con la sua tavolozza luminosa e chiara, con la sua felice spontaneità esecutiva riusciva in poche ore, con passaggi tonali delicatissimi, a realizzare una veduta perfetta nei minimi particolari, eppure da tanto lavoro non trasse alcun profitto, per il dissesto economico subito un paio di volte: prima a seguito del fallimento di un negozio di moda e novità aperto a Napoli e poi di una rivendita di generi alimentari aperta a Roma, ad uso dei suoi amici pittori, sicché si spense povero il 1 agosto 1887, a 68 anni.
Pittore eccelso di vedute, al pari del Gigante, seppe riprodurre con passione e minuziosità pae-saggi, marine, luoghi e monumenti, manifestando il suo grande pregio di ritrarre con sorprendente abilità gli effetti della luce, a seguito dei “molti e diligenti studi” con cui “impresse forte la natura nell’intelletto e acquistò una incredibile facilità nel dipingere, trovando sempre ubbidiente alla sua intenzione la materia e la mano, la quale ha pur tanto ferma che non adopera alcunché da pog-giarla… Singolarissimo riesce poi il nostro artista nel dar un colorito diverso a’ suoi quadri secondo le varie ore del giorno… con sì briosa verità, che ti destano una compiacenza nell’animo… in ogni lavoro che egli va compiendo manifesta una pratica e bravura straordinaria, specialmente nel trattare gli scogli” (B. Magni). “Anche nell’accento, dopo tanti anni di soggiorno a Roma ed altrove, rimase inesorabilmente napoletano”.4 Al suo soggiorno romano si riferiscono le opere Tempio di Vesta, Veduta del Colosseo, Veduta di Roma da Monte Mario, Campagna romana.
Non poche sue opere si ritrovano in collezioni private e importanti musei, anche all’estero (Francia, Inghilterra). In Italia si conservano: a Napoli il dipinto Marechiaro (Istituto delle Belle Arti), Ruderi del teatro greco di Taormina (Museo Nazionale di Capodimonte), Veduta del bosco di Persano con zattera sul fiume Sele (Palazzo Reale) e diversi acquerelli della raccolta Ferrara Denti-ce (Museo Nazionale di S. Martino); a Roma il dipinto Una roccia (Galleria Nazionale d’Arte Moderna), Pompei, due studi ad olio, Paesaggio e Veduta di Napoli, acquerelli, Casa di Torquato Tasso, disegno (Museo di Roma di Palazzo Braschi); a Giulianova Il Castello di Ischia e Porta Taormina (Pinacoteca Civica).
Lucera, sua città di nascita, non possiede, purtroppo, alcuna testimonianza della sua arte.
________
1. ANTONIO LUCARELLI, La Puglia nel Risorgimento. Dalla seconda Restaurazione borbonica alla Rivoluzione del 1820-21, Ed. Vecchi, Trani 1953, vol. IV, pp. 93-134-187. Dovette abbandonare Lucera nel 1822, dato che figurava ancora in carica agli esami dei 14 e 15 settembre 1821 (cfr. MICHELE D’AMBROSIO, Collegio-Liceo e Università in Capitanata 1807-1862, Stab. Tipol. Cav. L. Cappetta e F., Foggia 1970).
2. PAOLO EMILIO TRASTULLI, Alessandro La Volpe, “paesista valentissimo”, in PIER ANDREA DE ROSA – GIOVANNI SCHETTINO, Pittori e dintorni a Capri, Wendalina Editrice, Roma 2008, pp. 234-35, anche in Lucera luogo dell’anima (Catapano Grafiche, Lucera 2019).
3. Ibidem.
4. Ibidem.